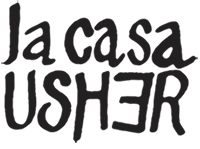|
|
|
|
|
| Rivista Internazionale di Semiotica e Teoria dell’Immagine Fondata da Omar Calabrese |
|
CfP Carte semiotiche – Annali 14
CALL FOR PAPERS CARTE SEMIOTICHE, ANNALI 14
L’argomento del prossimo numero è:
Garbology: rifiuti, arte, musei
The topic of the forthcoming issue is:
Garbology: waste, art, museums
Le sujet du prochain numéro est:
Garbology: déchets, art, musées
El tema del próximo número es:
Garbology: deshechos, arte, museos
editors Francesco Marsciani e Chiara Tartarini
Il tema dei rifiuti è parte dell’agenda socio-politica e culturale delle società globali, con una diversa distribuzione di consapevolezza tra i diversi paesi e le diverse aree di produzione, consumo, gestione e circolazione dei beni. Per parte loro, da più di un secolo, artisti di varia estrazione e reputazione hanno massicciamente utilizzato oggetti di scarto, selezionandoli sulla base delle loro qualità materiche, cromatiche, formali; li hanno risignificati, ibridati e assorbiti nell’arte, per gioco, in ossequio al sentimento della caducità o per denunciare violenze e lacerazioni di mondi immondi. Tra or e ordure, la spazzatura, insomma, ha già ampiamente dimostrato di poter essere sublime.
Ma i rifiuti (come oggetti, come motivi e come scarti produttivi), nel loro valore problematico di “cose rifiutate” e talora riprese e rivalorizzate, coinvolgono a più livelli e secondo più modalità anche i musei, ovvero i luoghi stessi che, nei casi più fortunati, espongono i prodotti di questa sublimazione riuscita e ormai convenzionale.
Se già alla metà degli anni ottanta il Centre Pompidou aveva ospitato la mostra Déchets, che, all’epoca in maniera innovativa, stimolava a riflettere su come trattare, trasformare o eliminare gli scarti, in anni più recenti le mostre sui rifiuti si sono moltiplicate, e su scala globale. Per limitarci alla sola Europa, pensiamo per esempio a Sopor/Garbage (Nordiska Museet, Stoccolma 2011), a Vies d’ordures (Mucem, Marsiglia, 2017) a Waste Age (Design Museum, Londra, 2021-2022) e soprattutto a Throw Away, che si è tenuta tra il febbraio 2023 e il gennaio 2024 presso la House of European History di Bruxelles. Gli obiettivi principali di questa mostra, poco sublimatori ma scientificamente inattaccabili, erano da un lato quelli di portare alla luce – o più letteralmente di “disseppellire” (unearthing) – la storia sommersa dei rifiuti, rinvenendovi i segni eloquenti dei cambiamenti storici e sociali, e dall’altro, come è d’obbligo, quelli di esporre oggetti prodotti da un design virtuoso, cioè realizzati con materiali riciclati e sostenibili. Tuttavia, la prima installazione, a pochi centimetri da una Venere degli stracci, presentava il grande ammasso di rifiuti prodotti dal museo nei mesi immediatamente precedenti all’inaugurazione della mostra.
Ora, la copia in cemento di una statua neoclassica semisommersa da centinaia di cenci diventa ben altro se è posta accanto a una catasta di immondizia prodotta dal/nel luogo che ne sancisce la pertinenza a un mondo “altro”; così le altrettanto celebri ordures, le accumulazioni, i materassi macchiati, persino le cattedrali decorate di cocci costruite pazientemente dagli artisti outsider, o le centinaia di vecchi abiti, pervicaci segni di assenza movimentati da grandi gru. È come se oggi i rifiuti uscissero di nuovo allo scoperto per ciò che sono, e fosse ormai chiaro a tutti che solo a pochi di loro spetta il privilegio di essere esposti in un cabinet di mogano della Tate. I più, ugualmente ben ripartiti e catalogati, saranno destinati alla discarica.
Nel loro fare, l’arte e i musei producono rifiuti, consumano materie, energia e scarti che ingombrano il mondo, di arte e non solo. E, tra l’altro, oggi sono gli stessi musei a soffocare per accumulo, tanto che negli ultimi anni si è ricominciato a parlare di deaccessioning, cioè dell’alienabilità di quegli oggetti non più degni di occupare spazio neppure nei depositi. I musei, da machines à collectionner (la definizione è di Rivière) quali erano, hanno iniziato a contemplare la possibilità di sbarazzarsi di quegli oggetti che, un tempo impregnati di significazione effettiva o virtuale, ormai sono scaduti in rilevanza. Ovviamente con cautela, in cambio di denaro e potendo sempre contare sulla permanenza delle loro tracce digitali e documentali.
Ne è derivato, però, un mix di stupore e sgomento, paragonabile, forse, a quello che ci procura l’“insostenibile pesantezza” delle esposizioni di cumuli di oggetti dismessi.
Cosa diventano i cosiddetti rifiuti nei musei? Quanto musei e gallerie si trovano implicati nelle stesse dinamiche, al contempo riflessive e direttamente responsabili, di produzione di rifiuti come cose materiali e come oggetto di pensiero? Che ne è dei magazzini, degli scantinati, delle opere d’arte che si decide di “depositare” nel limbo dell’inattuale, del “non ancora visibile”? Cosa viene davvero scartato? Che ne è del deperibile, dell’accumulo di ciò che ha acquisito un valore solo potenziale, dell’accaparramento compulsivo o viceversa della selezione maniacale sulla base di criteri discussi per principio sempre a monte? Che ne è di ciò che non rientra nei bilanci di gestione, negli investimenti necessari per la manutenzione, nelle politiche di promozione e di sviluppo? E soprattutto, che cosa si gioca nello spazio di attrito tra ciò che un oggetto “vale” e ciò che un oggetto “occupa”, tra ciò che può essere messo in risalto, illuminato dalle ribalte della promozione, e l’oggetto da espellere, da scavalcare, da spazzare via in quanto occupante indebito di uno spazio a cui non riesce ad essere ammesso? E ancora, sulla scala temporale, che ne è del rapporto tra l’attesa dell’oggetto di valore in gestazione, il suo trionfo, o quantomeno la sua realizzazione sul palco della messa in scena, e il suo trapasso, la sua decomposizione, nel dilemma sempre presente tra gli investimenti necessari per la sua conservazione e l’inesorabile trascorrere verso il nulla delle sue qualità?
Questo numero di Carte Semiotiche intende esplorare la relazione tra l’arte, i musei e l’oggetto rifiutato, alla luce del proliferare dei rifiuti come problema contemporaneo, per ciò che comporta nelle dinamiche della produzione e del consumo dell’arte, così come nelle sue modalità di gestione e di fruizione.
I rifiuti sono un problema di tutti, un intralcio e una minaccia: non concedono più una loro interpretazione nostalgica e, più che una musa, anche per artisti e musei, in modi più o meno virtuosi o scabrosi, impongono un confronto con il mondo “di fuori”. È evidente che nel momento in cui il rifiuto si trova coinvolto nei processi di riciclo, da un lato, e di esposizione, dall’altro, di scarto o di focalizzazione, tra l’essere l’emblema di un problema epocale e l’essere la rappresentazione di una logica generale del divenire, si pone il problema, tutto semiotico, della sua messa in discorso, ovvero della sua costruzione come figura significante, capace di trasmettere valori e carichi semantici. Prima di tutto, come si costruisce il rifiuto nella sua identità di “tipo di oggetto” o di “stato di oggetto”? Quali strategie ne valorizzano alcuni aspetti, in connessione con determinati programmi sia pragmatici che cognitivi, e quali altre possono o tentano di mascherare il fatto che la rappresentazione del rifiuto produce inevitabilmente rifiuti a propria volta? I discorsi enunciati, nelle molteplici sedi in cui si producono, cosa ci dicono delle istanze enunciazionali della loro produzione?
Quali tipi di sguardo si disvelano sotto le strategie di valorizzazione o di svalorizzazione? E ancora, perché l’arte e la sua promozione, che mettiamo al centro di questa indagine? Artificare il rifiuto sembra legato ad un modello socioculturale ormai inevitabile e creare, conservare, promuovere risultano altrettanti programmi che coinvolgono attori molteplici in ruoli attanziali determinabili e che le analisi dei casi, a loro volta sempre più numerose e critiche, possono permettere di identificare.
Questo numero di Carte Semiotiche intende mettere a frutto le capacità analitiche ed euristiche delle analisi testuali applicate ad una casistica variegata ma al tempo stesso compatta intorno ad una problematica che sembra andare imponendosi con sempre maggiore pervasività. Analisi testuale incentrata soprattutto, presumibilmente, sulle pratiche cui abbiamo fatto riferimento, ma che non escludono certamente opere o installazioni particolari, manifesti o operazioni rilevanti.
Di seguito alcune linee di ricerca, non esaustive, per i contributi:
1. La costruzione semiotica e discorsiva dello scarto
• Identità e tassonomia del rifiuto: strategie semiotiche per la costruzione del rifiuto come categoria (‘object type’ o ‘object state’); come il discorso etichetta, classifica e stabilisce il confine tra “oggetto” e “scarto”.
• Programmi pragmatici e cognitivi: Analisi dei programmi d’azione e di credenza che valorizzano o svalutano certi aspetti del rifiuto.
• Enunciazione e sguardo (gaze): analisi dei discorsi enunciati prodotti da musei e artisti per identificare le istanze enunciative e i tipi di sguardo veicolati (critica, denuncia, celebrazione)
• Il non-visibile e il limbo dell’in-attuale: i depositi e la gestione semiotica dell’oggetto nello spazio dell’assenza e dell’attesa di significato.
2. Il museo come produttore e gestore di rifiuti
• Museo sostenibile: l’impatto ambientale, energetico e materiale delle istituzioni d’arte (produzione, allestimento, logistica) e la semiotica delle politiche di sostenibilità museale.
•Valore e deaccessioning: il conflitto semiotico tra il valore storico/culturale di un oggetto e il suo costo di mantenimento/spazio.
• Obsolescenza e conservazione: l’obsolescenza degli exhibit tecnologici e il problema della conservazione di software e hardware come forme di scarto funzionale e concettuale.
• Tracce digitali dello scarto: il ruolo delle tracce digitali e documentarie nella gestione dello ‘scarto’ museale e semiotica della permanenza virtuale.
• Iniziative museali: case studies di mostre e/o progetti green theme/green design o di messa in scena del rifiuto con particolare attenzione alla loro efficacia semiotica.
3. Pratiche artistiche e ruoli attanziali
• Artificare il rifiuto: analisi dei programmi e dei ruoli attanziali coinvolti nella trasformazione dello scarto in opera d’arte e indagine semiotica sui luoghi di messa in mostra categoriale dello scarto (es. discariche come ‘musei’).
• Attivismo museale e significati etico-politici: analisi della costruzione del valore e dell’autorità morale da parte delle istituzioni (attivismo interno) e dei contro-discorsi (attivismo esterno) sui rifiuti e la crisi ambientale.
La redazione di Carte Semiotiche vi invita ad inviare proposte di contributo in italiano, inglese, francese o spagnolo (max. 2000 caratteri spazi inclusi o 500 parole) corredate di un breve profilo biografico (max. 10 righe) entro il 28 febbraio 2026 31 marzo 2026 ai seguenti indirizzi:
cartesemiotiche@semio-cross.it
Si accettano contributi in italiano, inglese, francese e spagnolo.
Indicazioni operative:
Lunghezza abstract: max. 2000 caratteri spazi inclusi (circa 500 parole)
L’abstract dovrà riportare le indicazioni di una bibliografia minima di riferimento
Lunghezza articoli: max. 40.000 caratteri spazi inclusi (circa 8000 parole)
Immagini: formato jpeg, png, 300 DPI, da inviare in cartella separata con file didascalie